-
La recensione di Eliana Camaioni a Le pentole del diavolo
-
La prima recensione a Le pentole del diavolo
 Gerardo Rizzo, con il suo terzo romanzo giallo “Le pentole del diavolo”, protagonista il delegato di pubblica sicurezza Baldassa di Castelfranco Veneto , rileva, con il suo scrupolo di storico, l’eterna lotta tra il bene e il male .Lo scrittore, anche in questa sua nuova opera, esalta la migliore tradizione gastronomica siciliana diventando di fatto ambasciatore della cucina messinese . Le pietanze del libro ,sono così ben dettagliate che sembrano preparate da lui medesimo. Cosi come sono tele le descrizioni di Messina e Taormina di fine 800.Il diavolo, si sa, fa le pentole e non i coperchi ed allora Rizzo mescola con il suo mestolo (la penna), gli ingredienti per un giallo avvincente e appassionante. Così le vicende personali dei protagonisti, la storia di San Filippo l’esorcista, i presunti colpevoli dell’omicidio di un avvocato girano vorticosamente nella pentola del diavolo . Ogni tanto l’autore li tira su dalla pentola quasi ad assaggiare il punto di cottura e anche per sfidare il lettore ad acciuffare il reo che sarà individuato appunto solo quando sarà trovato il coperchio giusto, tra colpi di scena e imprevisti(di Michele D’Andrea)
Gerardo Rizzo, con il suo terzo romanzo giallo “Le pentole del diavolo”, protagonista il delegato di pubblica sicurezza Baldassa di Castelfranco Veneto , rileva, con il suo scrupolo di storico, l’eterna lotta tra il bene e il male .Lo scrittore, anche in questa sua nuova opera, esalta la migliore tradizione gastronomica siciliana diventando di fatto ambasciatore della cucina messinese . Le pietanze del libro ,sono così ben dettagliate che sembrano preparate da lui medesimo. Cosi come sono tele le descrizioni di Messina e Taormina di fine 800.Il diavolo, si sa, fa le pentole e non i coperchi ed allora Rizzo mescola con il suo mestolo (la penna), gli ingredienti per un giallo avvincente e appassionante. Così le vicende personali dei protagonisti, la storia di San Filippo l’esorcista, i presunti colpevoli dell’omicidio di un avvocato girano vorticosamente nella pentola del diavolo . Ogni tanto l’autore li tira su dalla pentola quasi ad assaggiare il punto di cottura e anche per sfidare il lettore ad acciuffare il reo che sarà individuato appunto solo quando sarà trovato il coperchio giusto, tra colpi di scena e imprevisti(di Michele D’Andrea)
-
Network, il nuovo regalo di Mario Falcone

Dal cilindro di Mario Falcone, scrittore, sceneggiatore e poeta – e chissà cos’altro – salta fuori un noir che tiene incollati alle pagine, quattrocento in tutto, dense di tutti quegli ingredienti che fanno un buon libro, da bere fino in fondo. Network (EllediLibro 2024) immerge il lettore in un mondo che, apparentemente dorato e brillante, si rivela essere una sentina di nefandezze e una trappola dorata per giovani e adulti alla ricerca di gloria e di soldi. Un mondo che Falcone conosce bene, grazie al suo lavoro di creatore di storie.
Al centro del romanzo c’è l’assassinio di uno sceneggiatore, appunto, ma mica uno qualunque: Giancarlo Vannelli è il più importante personaggio nel mondo degli sceneggiatori, quello che decide per tutti, che può stabilire se un collega-rivale può lavorare o meno, che ha al suo servizio una squadra di giovani, aspiranti a entrare anche loro nel brillante mondo della fiction televisiva, anche grazie alla simbiosi con i responsabili della più importante rete di emittenti televisive, Network, appunto, che dà il titolo al romanzo.
Per tutti questi motivi, i personaggi che avrebbero un motivo per volere morto Vannelli sono tantissimi. E per questa ragione le indagini, sempre più complesse, faranno luce sul sottobosco di personaggi di quel mondo, dai cattivi assoluti, che molto spesso coincidono con quelli che occupano i posti più in alto, e guidano gli ingranaggi del meccanismo, ai buoni, quelli che da quegli stessi ingranaggi rimangono stritolati, venendone emarginati o addirittura rimanendone vittime.
Ma a risaltare, in un paesaggio sostanzialmente desolante, è soprattutto la figura dell’investigatrice, il vicequestore Daria Colonna, fortemente messa alla prova dalla vita e assediata da ricordi e rimorsi, per sfuggire ai quali si tuffa anima e corpo nel lavoro. Donna fortissima ma con le debolezze che covano dentro ciascuno di noi, nutre un profondo senso della giustizia, che va anche al di sopra del rispetto per le regole. Bravissimo Falcone a disegnarne il temperamento e il carattere, anche e soprattutto per la tempesta emotiva e sentimentale che Daria vive nei giorni dell’indagine.
Quattrocento pagine, dicevamo, e alla fine ne vorreste ancora.
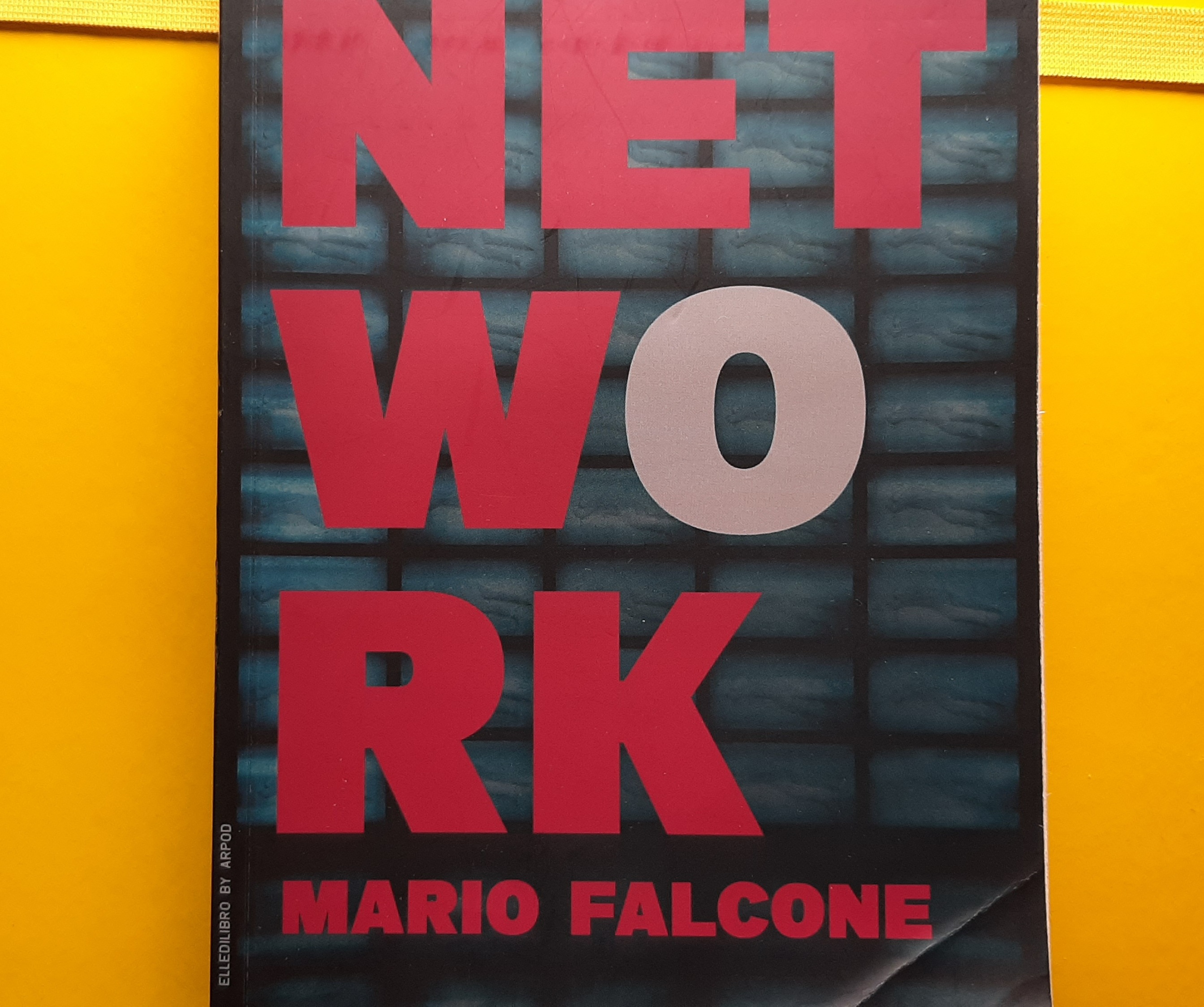
-
Un “pranzo” che compie cento anni, ma è ancora fresco


Ho letto, sebbene con qualche anno di ritardo rispetto alla sua uscita, un gustoso (la scelta dell’aggettivo non è casuale) libro pubblicato dalla Edas di Messina, Il Pranzo, di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara, o Amedeo Mallandrino, per brevità. Se volessi usare formule un po’ sfruttate, potrei dire che Mallandrino è “l’ultimo Gattopardo”, ma gliela risparmio… dirò invece che è un illustre discendente di famiglie aristocratiche che hanno segnato la storia di Messina e della Sicilia, come i Filangeri, i Piccolo – e di conseguenza Tomasi di Lampedusa – e i Cianciafara, borghesi ma non meno illustri. Non vive isolato dal mondo nel suo piccolo (si fa per dire) paradiso di villa Cianciafara, ma anzi si può dire che nel suo eremo il mondo lo accoglie, sotto la forma di conferenze, presentazioni ed eventi culturali di ogni genere. E lo stesso facevano le generazioni prima della sua.
Il Pranzo – che in realtà nel mondo dell’aristocrazia indicava la cena – racconta infatti un evento di gala tenuto a palazzo Cutò a Palermo, in via Lincoln, il 24 aprile 1924, e la ricorrenza centenaria mi è sembrata una buona occasione per ricordare il libro e consigliarne la lettura. Protagonista assoluta del libro come dell’evento è la contessa Maria Antonia, nonna materna dell’autore e moglie di Filippo Cianciafara, fotografo d’arte che, cugino di Giuseppe Tomasi e dei fratelli Piccolo, condivise con loro il talento e l’amore per il bello. Filippo meriterebbe una trattazione a sé, ma mi limito a rinviare al bellissimo libro dedicatogli da Dario Reteuna e pubblicato da Magika nel 2008 (L’occhio del Gattopardo. Filippo Cianciàfara Tasca di Cutò e la fotografia d’arte in Sicilia). Ancora i Gattopardi.
Eroina è quindi Maria Antonia, ma il deuteragonista è di tutto rispetto: è il personaggio in onore del quale Il Pranzo viene organizzato, il duca Amedeo d’Aosta, che con Maria Antonia vanta una frequentazione profonda. Mi rifaccio alle parole stesse dell’autore: “L’animo dolce ma focoso di lei, che già aveva falciato schiere di ammiratori, e la posizione altolocata di lui, non disgiunta dalla innata bellezza di entrambi, fecero sì che presto giungessero ad una convergenza di intese, una assiduità di relazione, una confidenza di legame, una intimità di rapporto, che non potevano sfuggire nei pettegoli ambienti dei salotti che frequentavano”. (Aggiungo la mia personalissima opinione che forse a regnare ci è andato il ramo sbagliato della famiglia…) Un ospite di tal fatta merita un’organizzazione senza sbavature: non mancano quindi i mille accorgimenti per una perfetta riuscita dell’evento, ma soprattutto non mancano le figure che renderanno possibile e perfetto tutto ciò. Il libro è il racconto di un evento mondano, ma si legge come un romanzo, e come un romanzo brulica di personaggi, che Mallandrino non manca di descrivere e spesso mostrare nelle foto che, assieme ad altri documenti, rendono ancora più prezioso il lavoro. Sono personaggi di alto lignaggio, ma anche personaggi solo apparentemente secondari, che si rivelano insostituibili: Francesco Denti, il maestro di casa, appartenente a un ramo cadetto di una famiglia aristocratica e per questo profondo conoscitore dell’etichetta e del protocollo; il monsù Pietro Monteleone, detto Pietrino, abilissimo a creare piatti che stuzzicano tutti e cinque i sensi; la squadra dei camerieri, gli ospiti e le altre figure di contorno, ognuna delle quali fornisce il proprio contributo a rendere memorabile la serata, di cui ricorre un centenario che meritava di essere ricordato.
-
Ustica, l’ansia della verità nel racconto di Giordano

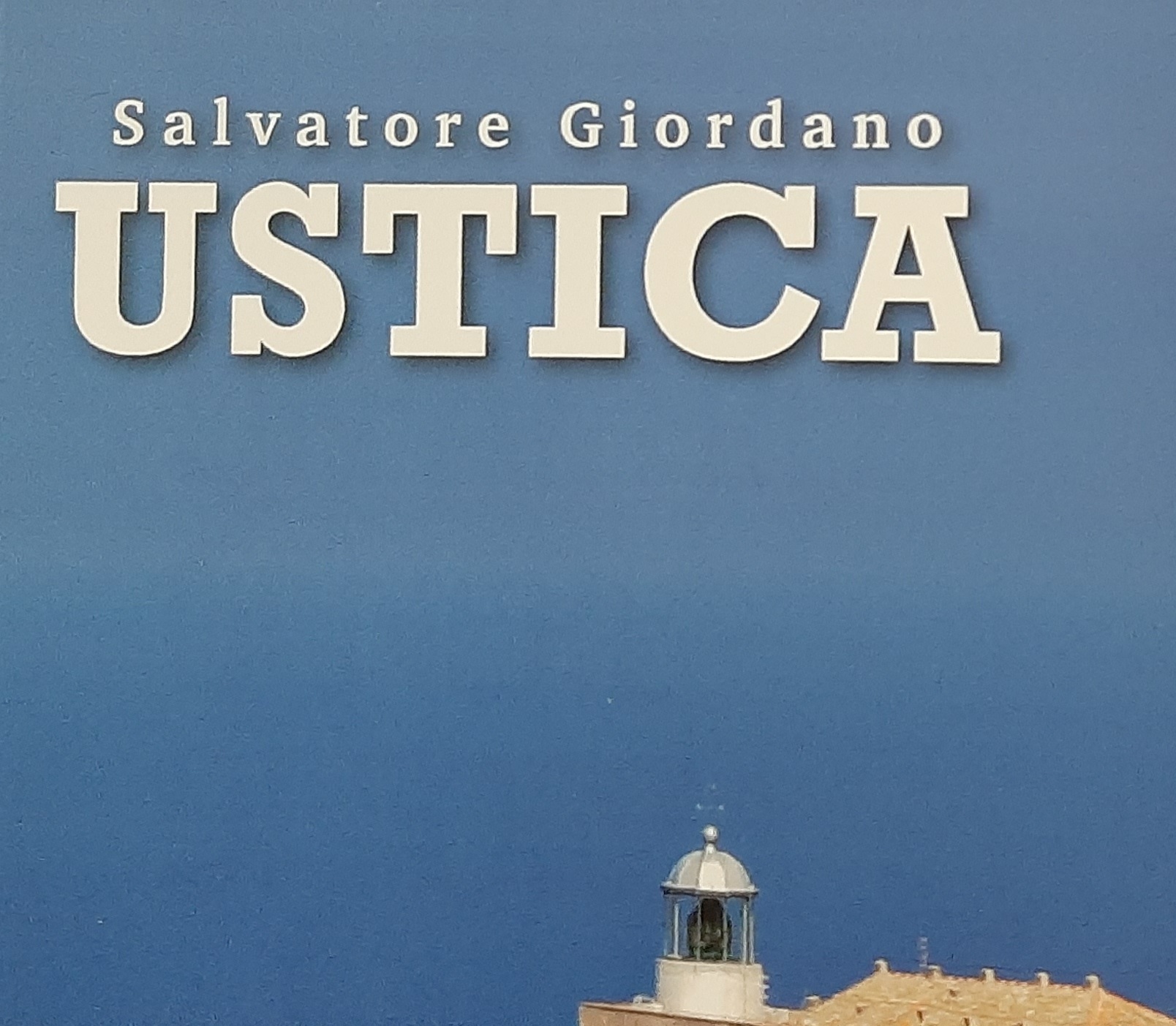
Marcello Gurretta è un giornalista, un po’ avanti negli anni, che ne ha viste di cose. Torna a Ustica dopo tanto tempo, troppo forse, e si dirige direttamente a cercare un posto alla pensione Alla Bastiana, gestita dal suo antico amore Elena. Scopre (o forse trova la conferma) che il suo sentimento si è conservato nel tempo, forse stemperato in un’amicizia molto profonda, ancora saldo, e forse pienamente ricambiato.
La Ustica è un luogo diverso da quello chiassoso della stagione estiva: Gurretta ci arriva e ci si ferma in un periodo tra l’autunno e l’inverno, quando l’isola ha una dimensione più privata e familiare. Non si capisce fino in fondo il vero motivo per il quale Marcello è andato via da Ustica lasciando Elena, e a lei che gliene chiede il motivo, risponde: “Sono mille le ragioni”, ma non la presenza di un’altra donna. “Voglio scoprire la verità”. Ed è la prima volta che la vicenda che la strage del 27 giugno 1980 fa capolino. È veramente difficile parlare di Ustica senza che i fatti di oltre quarant’anni prima emergano con il loro fardello di dolore.
Volendo, nel romanzo ci si potrebbero riscontrare alcuni tratti che ne fanno una sorta di “Locandiera” dei nostri giorni: una padrona di casa bella e uno stuolo di corteggiatori che le girano attorno in maniera più o meno discreta, e che sono n campionario dell’Italia a cavallo fra i due millenni. C’è Gurretta, che è l’intellettuale di sinistra che, se non uno scheletro, qualche ossicino nell’armadio sembra averlo, magari sotto forma di rimorso o di rimpianto. Ma altre presenze si aggirano nella pensione: l’antagonista, il generale Marzio Tambuto, vecchio insabbiatore, amico del potere, uno per il quale quelli che non la pensano come lui sono tutti “comunisti”. “Quelli come te sono come i cani da guardia dell’ortolano. Vincolati alla catena del loro padrone, mai riceveranno neanche una briciola di quel che difendono a rischio della propria stessa vita”. E ci sono Santo Nello Razza, sporco fino al midollo, che entra e esce dai tribunali come imputato o come testimone, e Rossano Mandra, un giovane ricercatore che suscita la simpatia di Marcello. Tutti in qualche maniera interessati ai fatti dell’80, che sembrano essersi dato convegno sull’isola.
E c’è infine la giovane, bellissima Beija, che pare destinata a riscattare un po’ tutti, per la quale Marcello sente risvegliarsi l’istinto paterno, e la mette in guardia dalle avances di Santo Nello Razza. È proprio Beija che vede una pila di libri su Ustica nella stanza di Marcello, e ingenuamente si chiede come possano esserci così tanti libri su un’isola. Ma non è dell’isola che parlano, quei libri, bensì della strage, le spiega il giornalista. E le parla del volo Itavia, dell’inchiesta parlamentare e di quelle dei giornali, del muro di gomma, dell’affondamento dei resti e del loro ripescaggio. Perché anche a distanza di oltre quarant’anni, si diceva, le ferite aperte da quella triste vicenda bruciano ancora, e uno come Salvatore Giordano – scrittore, professore di sociologia, editor e editore, ma anche e forse soprattutto uomo dotato di grande sensibilità civile politica e civile – non poteva esimersi dallo scriverne.
(Salvatore Giordano, Ustica, Nulla Die, € 14)
-
Lancia e Audi, e una passione lontana nel tempo

Molti di quelli che erano giovani e ragazzi negli anni fra i Settanta e gli Ottanta erano appassionati di rally. Quando ero ragazzino, imperversava un mostro che rispondeva al nome di Sandro Munari, che con una Lancia Fulvia HF a trazione anteriore arrivò a vincere un mitico Montecarlo nel ’72. Poi arrivò la Stratos, mostro anch’essa, e le vittorie si moltiplicarono. I rallyes diventarono trampolino di lancio per la produzione di grande serie, e il gruppo Fiat puntò tutto, con scelta felice, sulla 131 Abarth, una berlina da famiglia trasformata in macchina da corsa anch’essa (quasi) imbattibile. Per noi giovani del nordest siciliano, le gare erano il Rally dei Due Mari, il Rally dei Nebrodi e soprattutto il Città di Messina, tutte intuizioni vincenti di un Automobile Club molto efficiente e appassionato. Anche ad altri livelli, nelle gare mondiali, le auto italiane mietevano successi a ripetizione, almeno finché non cambiò il regolamento, ed entrarono in gara i mostri tedeschi a quattro ruote motrici.
Di questo passaggio parla Race for Glory, che racconta la stagione rallistica del 1983, in cui la Lancia faceva registrare l’ultima vittoria di una macchina a due ruote motrici, la mitica 037. È un po’ la storia di Davide contro Golia: della piccola, leggera e fragile Lancia contro la spaventosa Audi: potentissima questa, indistruttibile, che quasi non avevano nemmeno bisogno di controsterzi e dérapage, ché sembrava correre su binari dai quali era impossibile deragliare. La storia del limitato budget della casa torinese a fronte della potenza di fuoco messa in campo dal colosso di Ingolstadt. Dell’underdog Cesare Fiorio contro il tronfio Roland Gumpert dell’Audi.
Lo so, non è per niente detto che le cose stessero realmente così, ma lo dicono i titoli di cosa stessi: la storia è romanzata, e Fiorio non era certamente un outsider, anzi è il vero protagonista di tutta la vicenda. Chi seguiva il mondo delle corse in quegli anni, sa quanto abile e diabolico fosse il direttore sportivo della Lancia: all’intervistatrice che gli chiede quale fosse nella sostanza la natura del suo lavoro, Fiorio-Scamarcio risponde che è quella di prendere decisioni in tempo brevissimo, cosa che in più di un’occasione Fiorio fece in maniera egregia, come quella di convincere, per quell’impresa, il più grande pilota di tutti i tempi, il tedesco Walter Röhrl. Le scelte strategiche vincenti erano sempre state il marchio di fabbrica di Fiorio: qualche anno prima, grazie a una furbata, con la piccola Beta Montecarlo guidata da Riccardo Patrese, aveva soffiato il titolo al colosso Porsche nel Mondiale Marche gruppo 5.
Race for Glory è il tipico film da “ti sblocco un ricordo”, con qualche neo, come un doppiaggio di Scamarcio a se stesso che lascia un po’ perplessi, ma anche punti di forza, come la non invadenza delle scene di corsa rispetto alle dinamiche umane tra i protagonisti. Da segnalare le simpatiche apparizioni di quel bel tomo di Lapo Elkann nei panni del nonno Gianni Agnelli e – non ho trovato conferma in nessun posto ma ci scommetterei – una comparsata del vero Cesare Fiorio nella scena del party dopo la vittoria a Montecarlo.

-
Il triste vizio siciliano dalle radici antiche

Sembra che i siciliani abbiano una certa tendenza a idolatrare la propria classe dirigente. Non tutti i siciliani, ovviamente, magari una buona parte. O una parte, o una piccola parte, magari piccolissima. Però è sicuro che questa piccolissima parte di siciliani adora essere “cliente”, ama ossequiare e omaggiare i propri rappresentanti, che siano ai comuni, alla regione o al parlamento nazionale. E pare che questa tendenza siciliana abbia radici lontane, fino ai tempi della feudalità, che però dalle nostre parti è durata più che altrove, anche molto tempo dopo la sua ufficiale abolizione.
Forse è per questo che ci piace eleggere i nostri rappresentanti di riferimento non dopo un vaglio delle loro proposte, ma per appartenenza politica, per convenienza, per clientela appunto. O perché meglio ci sembrano incarnare quei modelli di signorotti feudali, che ci trattano un po’ come le loro anime morte. Non si spiega altrimenti che una parte di siciliani – sempre piccola, va da sé – possa arrivare a votare Lega e mandare al parlamento rappresentanti di quel partito: probabilmente il ragionamento è che se stavolta il signorotto si schiera con la Lega, è giusto che tutti noi gli si dia il voto.
Di recente mi sono imbattuto in un libro che un po’ spiega questa situazione, e che sembra fare degli interessanti paralleli tra i tempi andati e quelli presenti. Si tratta di L’ultimo principe di Sicilia, di Elio Manili (edizioni Bonfirraro 2023), una biografia romanzata di Ercole Michele Branciforte (1750-1814), ultimo grande esponente della più importante famiglia aristocratica siciliana, i principi di Butera: quello che vide il passaggio dall’età feudale a quella postfeudale.
Certo, Manili si avventura in territorio insidioso
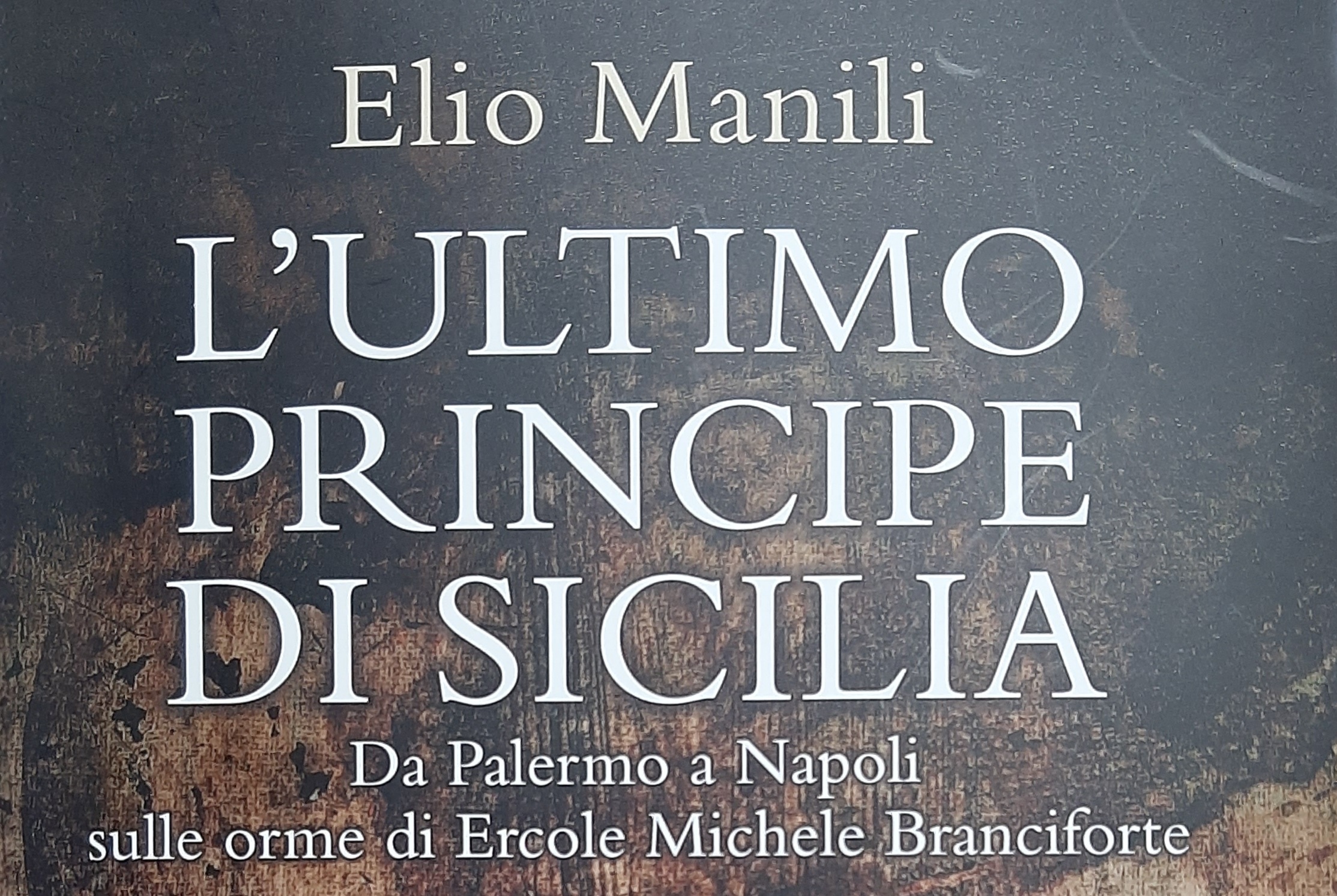 , perché quegli sono gli anni di cui ci hanno raccontato Luigi Natoli in Coriolano della Floresta e Leonardo Sciascia in Il Consiglio d’Egitto: anni di lotte tra corona e nobiltà, corona e popolo, e la nobiltà si frappone spesso a mediare. Soprattutto il Branciforte, con il famoso stemma del leone con le zampe mozze che tiene la bandiera: a dimostrare la grandezza della casata, quella non è una bandiera qualsiasi, ma l’orifiamma, il vessillo dei franchi. I Branciforte si vantano infatti di discendere da Obizzo, che durante una battaglia contro i longobardi, circondato dai nemici, difese strenuamente la bandiera del suo re rimettendoci le braccia: con un capostipite di tal fatta, i Branciforte dovevano essere per forza i principi più importanti di Sicilia.
, perché quegli sono gli anni di cui ci hanno raccontato Luigi Natoli in Coriolano della Floresta e Leonardo Sciascia in Il Consiglio d’Egitto: anni di lotte tra corona e nobiltà, corona e popolo, e la nobiltà si frappone spesso a mediare. Soprattutto il Branciforte, con il famoso stemma del leone con le zampe mozze che tiene la bandiera: a dimostrare la grandezza della casata, quella non è una bandiera qualsiasi, ma l’orifiamma, il vessillo dei franchi. I Branciforte si vantano infatti di discendere da Obizzo, che durante una battaglia contro i longobardi, circondato dai nemici, difese strenuamente la bandiera del suo re rimettendoci le braccia: con un capostipite di tal fatta, i Branciforte dovevano essere per forza i principi più importanti di Sicilia.Un principe così potente poteva a buon diritto proporsi come interlocutore fra le maestranze palermitane e il potere del viceré. Scendere a patti con i rappresentanti dei mestieri. Poteva diventare gentiluomo di camera del re Ferdinando, e avere notizie di prima mano. O al viceré stesso poteva opporsi: è il caso di quello che succede all’arrivo a Palermo di Domenico Caracciolo, di gran lunga il più odiato dall’aristocrazia siciliana. In una tornata di scherma con il principe di Villafranca, Ercole Michele gli annuncia l’imminente arrivo del nuovo viceré: “Ho avuto modo di conoscerlo a Napoli e vi assicuro che è un uomo tutto d’un pezzo, poco malleabile, e soprattutto è un fanatico delle nuove idee illuministiche”. “Si annunciano tempi molto difficili per noi?” “Temo proprio di sì. Comunque non dobbiamo piangerci addosso… Noi siamo troppo potenti e se lui darà fastidio faremo in modo di sbarazzarcene così come è avvenuto con il Fogliani”.
E in effetti Caracciolo, con le sue idee moderne, rappresentava un vero pericolo per i privilegi di clero e aristocrazia: avrebbe voluto addirittura chiedere un nuovo censimento di tutti i possedimenti terrieri, per poter suddividere anche tra i più ricchi il peso che fino a quel momento cadeva solo sulle spalle delle masse, e questo i nobili non lo avrebbero sopportato.
“E non solo”, si scandalizzava un altro nobile, il principe della Cattolica, “vuole dare la possibilità ai nostri contadini di andare a lavorare dove sono meglio pagati, riconoscendo loro il diritto di panificare e frangere le olive dove desiderano. Insomma, questo è un folle rivoluzionario che vuole condurci al lastrico!” Un vero pericolo…
Dal racconto della vita dell’ultimo grande feudatario siciliano, traspare forse una certa ammirazione da parte di Manili nei confronti del suo protagonista: manca forse – chiarissimo invece in Sciascia – un po’ di biasimo per il retaggio che quel sistema politico ha lasciato fino ai nostri giorni…
Mario Benante
-
Marcello Mento e quei giorni di Nietzsche a Messina

Tre settimane da raccontare. Ai confini del mondo. Nietzsche a Messina nel 1882 (Edas 2023) racconta le tre settimane trascorse nella nostra città da una delle personalità che maggiormente hanno inciso nella cultura europea dell’ultimo Ottocento e di buona parte del Novecento. Il libro, ultima fatica letteraria di Marcello Mento, è la ricostruzione minuziosa del soggiorno di Nietzsche a Messina, delle motivazioni che ce lo hanno spinto, delle testimonianze dirette e indirette, vicine e lontane nel tempo e nello spazio. Mento ha messo assieme – credo lo si possa dire con buona sicurezza – tutto quello che era possibile recuperare sull’argomento, su una pagina tra le meno note della biografia del filosofo tedesco.
Arrivò all’alba di sabato 1° aprile 1882, dopo un viaggio su un veliero mercantile chiamato “Angelina”, guidato da tale Domenico Barone.
Perché a Messina, in Sicilia, al sud, alla fine del mondo? Un po’, forse, Nietzsche vuole seguire le tracce di Goethe. I due viaggi hanno in comune più di un aspetto: entrambi non avevano comunicato a nessuno la meta del proprio viaggio; e tutti e due lasciarono la città in fretta e furia prima del previsto. Perché Messina, quindi? Meno di un anno prima, Nietzsche aveva chiarito in una lettera all’amico Heinrich Köselitz le caratteristiche che la sua meta deve avere: «E dov’è un paese con tanta ombra, cielo perennemente sereno, vento marino di forza costante dalla mattina alla sera, senza bruschi mutamenti del tempo? È laggiù, laggiù – che voglio andare! Fosse anche fuori dall’Europa!»
Così in quell’aprile Nietzsche parte: soffre il viaggio, al punto da essere sbarcato in barella privo di sensi. Quella che lo accoglie è una città cosmopolita, con una grande percentuale di stranieri, molto attivi. Il filosofo ci si potrà trovare a proprio agio.
È quasi sicuro che è al Leon di Francia che soggiorna, un albergo con poche pretese, ma con affaccio su piazza Duomo. Le notizie certe sul soggiorno messinese di Nietzsche non sono molte, a molte cose Mento ci arriva attraverso l’incrocio di tantissimi indizi recuperati dalle fonti più disparate, facendo ricorso all’esperienza di una vita intera da giornalista di inchiesta; e dove questi indizi mancano, sopperisce con l’intuito.
Un esempio? Nel periodo messinese, Nietzsche ebbe modo di spedire diverse cartoline e lettere: «Imboccò via dei Librai a passo svelto, quindi il corso Cavour per infilare l’ingresso dell’ufficio postale provvisorio che si trovava all’inizio di via Sant’Agostino». Lo fece? Non lo fece? Che importanza ha? In molti passi del libro, Marcello Mento smette deliberatamente le vesti del giornalista, e indossa quelle dello scrittore, supplendo alla carenza di dati con l’immaginazione: così è facile immaginare che la sera del Giovedì Santo Nietzsche, appassionato di musica, abbia assistito in Duomo all’esecuzione dello Stabat Mater di Pietro Raimondi, e il giorno successivo si sia lasciato coinvolgere dal clima delle Varette, per strada o dalla finestra della sua camera.
Ma pur tra le tante incertezze, diversi punti fermi ci sono: il primo è che a Messina il filosofo ci stava davvero bene, ci si sentiva a proprio agio, coccolato dai messinesi («Non fanno altro che viziarmi») e confortato dai prezzi bassi di ogni cosa, come testimoniano le cartoline alla sorella. Tra le poche certezze ci sono un bagno nelle acque dello Stretto, dove conobbe la forza delle correnti e dei mulinelli, e un’escursione a Castel Gonzaga, dove «in lui emerse qualcosa di profondo, di assoluto, la consapevolezza di aver raggiunto uno stato di liberazione da tutto ciò che lo condizionava».
Lo stato di grazia messinese durò solo tre settimane, come detto, poi dovette partire, fuggire quasi, a causa di una sciroccata che ne minò la stabilità fisica e psicologica. Ma quelle tre settimane sarebbero state proficue per la sua produzione filosofica e letteraria, importanti per la rifinitura di quegli Idilli di Messina che proprio nella città dello Stretto avrebbe limato e completato.
Rimane un punto interrogativo, ma grande quanto una casa, che Mento si porta dietro da anni: per alcuni giorni la presenza di N a Messina coincise con quella di Richard Wagner. I due illustri tedeschi avevano avuto in passato una profonda amicizia, che divergenze di pensiero avevano spezzato. Mentre il filosofo passava i suoi giorni nel modesto Leon di Francia, il musicista concludeva il suo lungo soggiorno siciliano, durato svariati mesi, nel lusso dell’hotel Trinacria, in una delle “isole” più prestigiose della Palazzata. Nei giorni messinesi i due si incontrarono? Nulla sembra lasciar pensare questo, ma l’idea che Messina avrebbe potuto essere il teatro dell’ultimo incontro di due personalità così grandi continua a essere davvero suggestiva…

-
Quando pensi che forse l’hai fatta grossa…

Mi sono soffermato a guardare una delle tante foto dei festeggiamenti della Lega quando la proposta di legge sull’Autonomia-Raccolta-Differenziata ha superato l’esame dell’aula di Palazzo Madama. Spicca la giusta soddisfazione di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega alla Camera, quello che conduceva i programmi con l’intervento degli ascoltatori a Radio Padania. “Padania Libera!!”: ha ben ragione di essere contento. Poi si vede una donna che sta stendendo i panni. No, non sta stendendo i panni. È Mara Bizzotto: sembra una delle tante donne che stavano sotto il palco del comizio del Ku Klux Klan in Mississippi Burning. La razza bianca superiore (se non vi ricordate la scena riguardate il film, se non l’avete visto, fatelo). Mostra la bandiera di San Marco. E poi, appena più in basso, il nostro eroe, Nino Germanà. Sorride, un po’ forzatamente direi. A Messina diremmo che ride comu l’anciuleddu d’a Vara, e un buon messinese sa bene cosa significhi. Guarda la scena e si gratta la testa come chi non sa esattamente cosa pensare (e anche io veramente ho qualche dubbio). Forse pensa: “perché la signora qua dietro mostra il logo delle Generali? Forse le assicurazioni sono sponsor?”. O forse si rende conto di averla fatta davvero grossa, e gli tornano a galla le spiegazioni del prof di lettere che gli raccontava di Antenora, la zona dell’inferno in cui si punivano i traditori della patria? Come Antenore, il troiano che aveva consentito il fatale ingresso degli achei. No, troppo lusso. Però il disagio si vede, si legge, salta fuori dalla fotografia. Forse si sente un po’ Giuda, e se è così, che lo faccia fino in fondo (in senso metaforico, va da sé…)

-
Il romanzo di Tommaso Campanella

Ogni tanto capita di imbattersi in un libro e in un autore che non si era mai sentiti nominare, poi si scopre che l’autore, Dante Maffìa, è uno dei più prolifici scrittori calabresi, sicuramente da rivalutare.
Il libro è Il romanzo di Tommaso Campanella, in cui la vicenda terrena del filosofo di Stilo viene raccontata in un numero di pagine piuttosto contenuto: il focus dell’autore si concentra infatti su alcuni aspetti della vita di Tommaso. Uno di questi è la prima formazione del futuro filosofo: Maffìa ci mostra un piccolo Giandomenico – questo era il suo nome di battesimo – figlio del ciabattino di Stilo, nel reggino, che “ruba” le lezioni del maestro nascondendosi dietro il muretto della scuola.
Campanella vive in un periodo in cui contrastare la cultura ufficiale può rivelarsi estremamente pericoloso: basti pensare ai casi di Giordano Bruno, arso a Campo de’ Fiori, o di Galileo Galilei, che si salva solo grazie a una tempestiva quanto umiliante abiura. O a quello del cosentino Bernardino Telesio, che aveva osato, tra i primi, approcciare la scienza attraverso l’esperienza piuttosto che mediante l’autorità. Proprio l’omaggio di un Campanella ventenne al suo ispiratore Telesio, nel 1588, nella narrazione di Maffìa, comincia a metterlo in cattiva luce agli occhi della Santa Inquisizione: non si poteva accettare che un frate domenicano potesse appoggiare un potenziale eretico come il cosentino.
Il racconto di Maffìa si snoda per periodi, e si sofferma su alcuni episodi chiave, come il sogno di realizzare nella sua Calabria una repubblica (che ricordava molto quella “Città del Sole” vagheggiata nel suo famosissimo libriccino), il suo fallimento e la lunga prigionia nelle carceri di Napoli. Una prigionia che dura ventisette anni, che però non riuscirà a piegare la ferrea volontà di Tommaso, che riesce a procurarsi libri da leggere e carta per scrivere, combattendo ogni giorno con gli scarafaggi, i topi, il buio e l’umidità.
Il libro si conclude con il funerale del filosofo a Parigi, omaggiato da Luigi XIII che lo aveva accolto a braccia aperte dopo la scarcerazione e un rocambolesco trasferimento in Francia.
Una suggestiva interpretazione della figura del filosofo, sulla cui vera essenza anche Norberto Bobbio, che scrisse la prefazione di una delle edizioni, non aveva voluto dare una definizione univoca e definitiva.

-
Abbonati
Abbonato
Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.